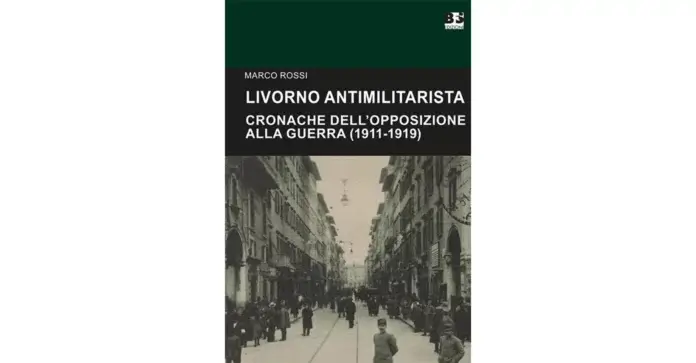Ghezzano, Bfs, 2025, pp. 192, € 19.00.
Marco Rossi, tra i maggiori studiosi ed autori per la storia libertaria e di insubordinazione in Italia, ha nella sua cifra la disamina del nesso combattentismo – sovversivismo, venuto in essere con gli sconvolgimenti sociali e politici del Primo dopoguerra. Sul piano nazionale ed anche internazionale ma sempre con un occhio di riguardo per le vicende della, per molte ragioni significativa, realtà di Livorno.
In questo caso, l’Autore compie una sorta di passo indietro, attraverso l’analisi del principio di quel breve interludio tra l’Italia com’era prima e quella che sarebbe stata poi, con la Guerra europea, in seguito detta Grande guerra e Prima guerra mondiale.
Il tema centrale della monografia è come affronta il movimento operaio l’entrata dell’Italia in guerra e quali siano i diversi comportamenti e misure adottati durante le svolgimento del conflitto.
Non è di per sé una trattazione teorica ed astratta del dibattito interventismo/ neutralismo, pur inevitabilmente presente, ma una restituzione delle sue ricadute nella vita concreta di donne e di uomini che facevano capo alle organizzazioni di classe e che, come la stragrande maggioranza della popolazione, questa guerra perlopiù non la volevano.
C’è, a riguardo, una parte introduttiva dal valore propedeutico sulle guerre coloniali d’Africa che avevano segnato il nostro periodo postunitario con in nuce le posizioni e le contraddizioni che avrebbero caratterizzato l’ingresso nella Grande guerra: la Disfatta di Adua (1896) e la Guerra italo – turca di Libia (1911–12).
La ricerca poggia su una consistente bibliografia, sulla documentazione d’archivio: gli archivi di Stato e l’immancabile Casellario politico centrale, per seguire le tracce delle personalità menzionate, e sulle fonti a stampa dell’epoca. A Livorno, la radicata presenza della compagine sovversiva, e la relativa massiccia diffusione dei suoi organi di stampa, ha fatto sì che i periodici delle forze proletarie giungessero a noi in numero soddisfacente. L’analoga stampa locale anteguerra delle altre zone del Paese è in larga parte andata persa, principalmente nei roghi dello squadrismo fascista o, comunque, per via dell’assalto del tempo. Per cui, oltre alle carte d’archivio, bisogna spesso far ricorso alle, comunque utilissime, cronache di parte avversa, invece conservate dal Regime fascista.
Che cosa si deduce dalla lettura di questo volume? Attraverso la lente dei trascorsi labronici, emerge in tutta evidenza come l’interventismo fosse un’espressione elitaria, trasversale alle culture politiche: uno di quei fenomeni, come sovente capita, estremamente minoritari di una società che finiscono per prendere il sopravvento in tempi sorprendentemente brevi. A Livorno l’interventismo di piazza è espressione dei circoli borghesi. La classe operaia ne è, per indole e tradizione, sostanzialmente estranea. I socialisti, che ne sono politicamente i principali rappresentanti, si cullano nell’illusione, tanto per cambiare, che sia grazie a loro se l’Italia si attarda ad entrare in guerra e, da consuetudine, restano lì, in balìa degli eventi, aldilà dell’impegno dei singoli. Invece, negli ambienti repubblicani e, in maniera minore, in quelli anarchici si fa largo l’ipotesi di partecipazione all’agone bellico in nome della libertà dei popoli oppressi dagli imperi centrali, nella convinzione che il proletariato debba comunque essere partecipe agli sconvolgimenti storici per trarne vantaggio e, non si sa mai, ricavarne pure una rivoluzione sociale. È lo spirito dell’interventismo di sinistra, quello non nazionalista, le cui origini si possono rintracciare nel volontarismo garibaldino e nel Risorgimento democratico, quello dei cosiddetti precursori, i giovani partiti volontari per la Serbia e la Francia quando Mussolini era ancora neutralista. Uno spirito che si sarebbe infranto sull’immane tragedia del Fronte e sull’assenza di sbocchi rivoluzionari, almeno in Italia. Ciononostante, tra gli interventisti non tutti avrebbero abbandonato i propositi rivoluzionari, anzi. Lo si sarebbe visto di ritorno dal Fronte, a Livorno come altrove, quando ai Combattenti di guerra sarebbe spesso spettata la guida delle battaglie sociali e politiche della classe lavoratrice, contadina ed operaia. Lo si sarebbe visto dianzi alla violenza filopadronale e quindi antioperaia del movimento fascista, quando l’idea d’una efficace contrapposizione ad esso sul campo maturò proprio in seno al combattentismo e all’arditismo. Il fascismo ha infatti avuto difficoltà a radicarsi laddove non era riuscito a monopolizzare l’associazionismo combattentistico e gli esponenti dell’interventismo. Gli Arditi del popolo, d’indubbia matrice trincerista, avrebbero infine trovato adesioni ed appoggi anche tra le personalità e le culture già d’espressione neutralista. La lotta militante contro i Fasci avrebbe giocoforza raccolto assieme l’eredità complessa del cosiddetto diciannovismo — e nel 1919 si ferma indicativamente la ricostruzione fatta nel saggio -, e delle battaglie contro la guerra del 1917, preambolo di ciò che sarebbe avvenuto nel Biennio rosso, una volta certo rimescolate le carte in tavola con il rientro dal Fronte.
La ricostruzione compiuta dall’Autore ci trasmette tutto lo spirito del tempo, della Livorno e del circondario nel periodo in oggetto, con i luoghi, i fatti e le persone. Elementi che possono far riscoprire il senso di appartenenza ad un comunità, ben oltre l’erudizione localistica.
Silvio Antonini